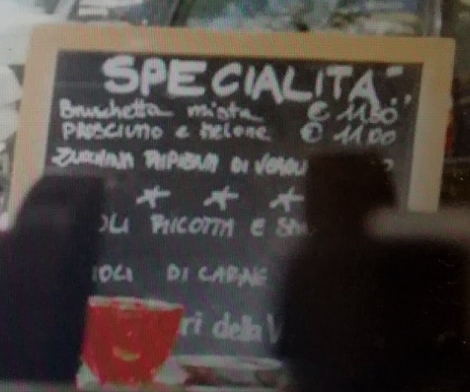A mio parere i bambini sono dei soggetti di studio interessantissimi, nel senso scientifico e comportamentale. Potrei passare ore a guardare su YouTube video di bambini sottoposti a vari “esperimenti” comportamentali e osservare come una differenza di età di pochi mesi possa avere così tante ripercussioni. Mi stupisce vedere come effettivamente i bambini sotto una certa età non siano in grado di concepire i concetti di spazio e tempo come noi adulti. Il concetto del sé.
Mi ritrovo a guardare questi video e a pensare “se solo sollevassi il tuo stesso piedino, riusciresti a spingere il carrellino, forza, ce la puoi fare”. Eppure, un bambino sotto i 18 mesi non può farcela, non è colpa sua: non ha ancora sviluppato consapevolezza del suo stesso corpo.
Un’altra importante abilità di vita quotidiana che i bambini acquisiscono gradualmente a partire dai sette mesi è il concetto della permanenza dell’oggetto. Prima dei sette mesi, il bambino considera esistente ed ottenibile solo ciò che vede: se un oggetto non è più nella sua visuale, esso cessa di esistere. Così, allo stesso modo, se un genitore esce dalla visuale del bambino, anch’egli cesserà di esistere. Comprendendo questo punto di vista, inizia ad essere quasi più comprensibile o razionalizzabile il timore della separazione nel bambino.
Dopo i sette mesi, tuttavia, qualcosa cambia: il bambino inizia a concepire l’idea che un oggetto continui ad esistere anche quando non è più nel suo campo visivo, che quell’oggetto, riposto in un determinato luogo, è molto probabile che rimarrà in quel luogo e potrà essere cercato e ri-ottenuto.
Se la permanenza dell’oggetto è, di norma, una capacità che tutti acquisiscono naturalmente, forse c’è un’altra accezione di permanenza che potrebbe venire a mancare e che dovrebbe essere allenata anche negli adulti. L’idea di permanenza dell’affetto è un concetto che, detto in parole povere, non penso sia stato teorizzato da nessuno, se non da me dopo aver speso troppo tempo nella mia testa, ma ci tenevo a sviluppare questo concetto. (E se davvero esiste qualche teoria simile, sarei molto interessata a leggerla!)
Premettendo che non ho una relazione a distanza, ecco un esempio di vita vera (la mia).
Dopo aver passato il fine settimana con il mio ragazzo, al momento di salutarsi spesso vengo colta da un timore da separazione, una sensazione minima, eppure fastidiosa, poiché va a turbare la quiete delle ore precedenti. Se mentre sono insieme a lui nella stessa casa sono tranquilla anche quando siamo in stanze diverse a fare cose diverse, nel momento in cui vado via è come se una parte di me temesse che l’allontanamento possa provocare un’interruzione dell’affetto che c’è tra noi. E così, metto in atto un comportamento rafforzativo, concentrato negli ultimi minuti prima di andare via, in cui esterno ancora di più il mio affetto e ripeto mille volte di aver passato una bella giornata.
Poi vado via, a metà tra tranquillità e ansietta. So che lui si è divertito con me, me l’ha detto esplicitamente, me lo dice sempre… ma ora che sono andata via, continuerà a pensare che si è divertito veramente? Ora che non sono più presente e lui tornerà al suo hobby, continuerà a pensare che è felice con me?
(Forse un articolo sul blog non è il luogo più adatto a sviscerare queste domande, meglio una seduta dallo psicologo e, credetemi, ci sto lavorando :P)

Una delle ultime volte in cui mi sono capitati questi pensieri, dunque, è nato questo collegamento: così come un bambino non riesce ragionevolmente a concepire che un oggetto possa continuare ad esistere anche quando è fuori portata, mi è parso quasi che dovessi convincere con le buone il mio cervello a capire che l’affetto tra due persone può continuare ad esserci anche quando non sono nello stesso raggio.
Sicuramente le motivazioni alla base delle due “impermanenze” sono diverse: quella d’affetto potrebbe essere legata alla fiducia che riponiamo nel partner, o che abbiamo (mal)riposto in partner precedenti e che adesso si ripercuote in paure e aspettative. Per quanto mi riguarda, questo dubbio dell’impermanenza non riguarda solo l’affetto che gli altri provano nei miei confronti, ma anche l’impermanenza dell’affetto che provo io nei confronti degli altri, e non raramente mi sono seriamente domandata: se adesso improvvisamente mi ritrovassi da sola, se non vedessi più le persone che sono abituata a vedere, ne sentirei la mancanza?
Una volta fuori dal campo visivo inizio a mettere in discussione la veridicità e la reale esistenza di affetto. (Im)permanenza dell’affetto. E non è molto piacevole coesistere con queste domande e questo timore. Questo doversi quasi accertare di avere un cuore che batte e che prova sentimenti, o doversi accertare – o meglio, dover fare del proprio meglio per fidarsi del fatto – che le persone che ci vogliono bene credono davvero al fatto che ci vogliano bene.

Ovviamente, la parte più razionale del mio cervello sa qual è la risposta a queste domande. Sì, l’affetto continua anche quando esistono tutte quelle distanze fisiologiche di una normale vita quotidiana. No, così come sai che un oggetto riposto in un cassetto continuerà a trovarsi in quel cassetto, allo stesso modo l’affetto non cessa di esistere solo perché la persona oggetto di quell’affetto è in un altro compartimento di vita.
La parte razionale del mio cervello lo sa… il problema è la parte non razionale, la parte un po’ alla san Tommaso, che se non vede non crede.
Molto probabilmente è una questione di fiducia, in se stessi e negli altri, e spero vivamente che la fiducia possa essere allenata come una qualsiasi buona abitudine. Nei momenti di insicurezza, tuttavia, cercherò conforto in questa possibile similitudine e mi dirò: PERMANENZA DELL’OGGETTO, ALESSIA, PER-MA-NEN-ZA. E spero che questo punto di vista possa essere utile anche a qualcun’altro tra voi.
Alessia xx